Tradimento
Bentornati al Volo del Dodo, il blog che segue la notte degli Oscar solo per vedere il balletto dei Lego. Il 13 Marzo siamo al Darwin Day di Parma, l’avvenimento annuale che è un po’ il Lucca Comics della biologia (insieme ad Entomodena) per noi italiani. Solo meno cosplayer e più insetti sociali.
Le 50 sfumature di banalità a cui Hollywood ci ha recentemente abituati colpiscono in maniera particolarmente dura il tradimento. La scena si svolge con poche variazioni sul tema: il/la protagonista (P) e il/la sua amico/a (A) sono compagni da per sempre e si vogliono pacchi di bene. All’improvviso P vince la competizione per il migliore castoro di cartapesta fatto con i gomiti e A, inquadrato di lato alla premiazione, si rode il fegato perché a quel tavolino in compensato messo in palio ci teneva. Alleandosi più o meno a lungo con il/la cattivo/a (C) di turno A cerca vendetta su P salvo cadere in preda a rimorsi di coscienza. Alla fine tutti sono amici di nuovo, A accetta il suo ruolo di eterno secondo e si va tutti a fare una mangiata di ciccioli sociale.
Sipario. Sono 8 euro e cinquanta grazie.
Siccome noi ci si è anche rotti le palle alla grande di ‘sta cosa usciamo dalla sala e ci rivolgiamo all’unico posto in grado di garantirci una tradimento fatto per il verso. Le risoluzioni ONU La Natura. Per trovare una associazione tra due specie diverse simile a quella che possiamo avere tra due amiconi non dobbiamo guardare lontano, ci basta cercare il termine mutualismo.
Possiamo definire il mutualismo come una relazione tra due organismi dalla quale i partecipanti traggono un beneficio, generalmente inteso come aumento di fitness, a discapito di un costo. Tradotto in soldoni i membri di due specie diverse formano un’alleanza più o meno lunga (e più o meno esclusiva) che conviene ad entrambi. Attenzione però. Quando un animale sparge i semi di una pianta non lo fa certo per buon cuore, ma unicamente perché quest’ultima li aveva messi dentro ad una struttura appetitosa e che valeva la pena mangiare: il frutto. Ecco una cosa che serve tenere bene a mente: il mutualismo non è un altruismo sotto mentite spoglie. Ciascuna delle due specie che partecipano all’interazione persegue il proprio interesse.
Punto.
Anche spogliato da una sua accezione più nobile, il mutualismo rimane una strategia molto diffusa in natura. Pensate alle angiosperme, le piante che fanno fiori. I tre quarti di tutte queste piante vengono impollinate grazie ad animali (insetti, ma anche chirotteri o uccelli) che trasportano il polline per lunghe distanze altrimenti non raggiungibili dalla pianta. So che sembra una boiata ma ‘sta roba è essenziale per favorire il flusso genico tra organismi stanziali. Le piante hanno così accesso a partner che difficilmente riuscirebbero a raggiungere altrimenti e, dal canto loro, gli animali si assicurano una scorta di pregiato e nutriente nettare. Ci sono casi di tradimento tra questi partner? Boh sì, ma anche chissene, non siamo emotivamente coinvolti da chi frega una pianta. Le piante se lo meritano. Dobbiamo cercare due animali e, tra questi, non c’è caso più noto del mutualismo tra afidi e formiche.

Una formica che intratiene una stretta relazione con degli afidi. Se andate avanti scoprite perché. Immagine Wikimedia Commons
Esistono più di 4000 specie di afidi, un puttanaio se consideriamo che tutti i mammiferi sul Pianeta, dalla balenottera azzurra (Balenoptera musculus) al toporagno Thor (Scutisorex thori), ammontano a poco più di 5000 specie. Questi insetti possono anche vantare una storia evolutiva lunghetta, risalente almeno al Permiano (280 milioni di anni fa), ben prima che i dinosauri facessero la fila per essere addestrati da Star-Lord. Un’altra caratteristica intrigante degli afidi è il modo in cui si riproducono. Alcune specie alternano riproduzione classica, in cui il maschio e la femmina si conoscono e fanno robe dopo una deludente puntata di Masterchef, a quella partenogenetica. In questa ultima modalità da una femmina nascono figlie senza necessità di fecondazione da parte di un maschio. Questa tecnica raggiunge il suo apice con il fenomeno delle generazioni telescopiche, famose negli afidi, in cui una femmina contiene al suo interno una figlia che è, a sua volta, già partenogenicamente incinta di un clone. Afidception. Gli afidi si nutrono di linfa elaborata, il che li costringe a rimanere esposti sulla superficie di un vegetale anche per lunghi periodi. Alcuni hanno addirittura delle appendici buccali lunghissime per perforare il legno, strutture che poi non sono in grado di ritirare abbastanza in fretta per permettergli di sfuggire ai predatori. Se tutto questo vi sembra rischioso per un afide non avete tutti i torti. Questi insetti hanno le capacità difensive di un orsetto del cuore.
Fortunatamente c’è chi guarda loro le spalle, per il giusto prezzo.
La linfa elaborata è una sostanza contenente un sacco di sostanze zuccherine, ma poco azoto. Sfortunatamente questo elemento è essenziale nella dieta degli afidi (degli animali in genere) quindi, per ottenerne un quantitativo decente, questi insetti devono processare un sacco di linfa. Tutte questo eccesso di zuccheri deve essere espulso dal corpo, e gli afidi lo fanno producendo una sostanza caratteristica chiamata melata. Se l’idea di escrementi zuccherini non vi solletica particolarmente sappiate che siete in netta minoranza: la melata è una leccornia apprezzata da un sacco di specie diverse, incluso l’uomo. Diverse popolazioni delle regioni aride sono solite raccoglierla, mentre il miele che ci si può ricavare, scuro e meno dolce di quello classico, è particolarmente apprezzato nell’Europa centrale. Ma, probabilmente, nessuno ama la melata più delle formiche.
Questi insetti sono soliti proteggere intere mandrie di afidi, raccogliendone la melata e assicurando così pulizia da eventuali funghi patogeni e ricevendo in cambio una scorta di cibo. Alcune specie di formiche proteggono addirittura le uova di afide all’interno della loro colonia, per assicurarsi una nuova generazione di produttori di melata. Diverse famiglie di formiche hanno sviluppato questo rapporto mutualistico con gli afidi, come i Formicinae, i Dolichoderinae e i generi Myrmica e Tetramorium. L’interazione tra questi due partner rappresenta uno splendido esempio di mutualismo, un mirabile caso di coevoluzione.
Sarebbe davvero brutto se qualcuno tradisse l’altro.
Paracletus cimiciformis è un afide con un ciclo vitale rappresentabile da un immagine assurdamente complicata. Questo piccolo insetto può riprodursi “classicamente” e per partenogenesi, utilizzare come nutrimento specie diverse di piante, possedere ali o no.
Se zoomiamo ad un determinato periodo della sua vita, quando vive associato alle radici delle piante erbacee, notiamo che P.cimiciformis può assumere due forme ( fenomeno di polimorfismo, occhio a non confonderlo con il suo significato genetico). La cosa strana è che altre specie di afidi strettamente imparentate con P.cimiciformis, in questo periodo della loro vita, ne hanno solo una. Questi due stadi sono entramb caratterizzati dall’assenza di ali e distinguibili soprattutto dalla forma del corpo: una è bianca e piatta, l’altra verde e rotonda. Ciascuna di queste forme è in grado di produrre l’altra per partenogenesi aggiungendo, se possibile, ulteriore caos alla vita di questo minuscolo insetto. Come avrete sicuramente notato dallo schema questa specie di afide ha come amicone Tetramorium semilaeve, una formica abbondante nella penisola iberica. Con lei intrattiene la solita relazione di melata in cambio di protezione, ma con una nuova e inquietante differenza.
Adrián Salazar e i suoi collaboratori hanno notato che quando le formiche incontravano un P.cimiciformis rotondeggiante muovevano le antenne e, in risposta, l’afide produceva la tanto agognata melata. Classico e affidabile mutualismo. Quando invece un esemplare di T.semilaeve incontrava un afide dalla forma piatta le cose andavano diversamente. Dopo il movimento delle antenne l’afide rimaneva immobile e, dopo qualche istante, la formica caricava l’insetto e lo portava dentro la colonia. L’afide in questo modo veniva a contatto con diverse altre formiche operaie, che lo pulivano e accudivano leccandolo, fino a portarlo nel luogo più sicuro della struttura.
La camera delle larve.
Qui l’afide si ritrovava improvvisamente circondato dai piccoli del suo partner, coloro che sviluppandosi avrebbero assicurato protezione e pulizia alle generazioni future di P.cimiciformis. Dopo una breve ricognizione, l’afide andava a posizionarsi vicino ad una larva e, con un movimento rapido, la infilzava per succhiarne l’emolinfa.
Ma come fa un parassita sociale a farsi trasportare fino al cuore della colonia e a colpire indisturbato là dove le difese delle formiche sono più forti? Salazar e i suoi colleghi hanno pensato che la risposta potesse essere chimica, in quanto la maggior parte delle comunicazioni nelle formiche avviene tramite emissione di particolari sostanze che vengono captate dalle compagne. Analizzando la cuticola (l’esoscheletro) degli afidi e delle larve di formica gli autori hanno trovato che la forma piatta di P.cimiciformis e le larve erano caratterizzate da quantità simili di alcuni idrocarburi, mentre gli afidi rotondeggianti non li avevano o ne producevano in piccolissima parte. Impregnando dei fantocci di un “estratto di afide piatto” gli autori hanno anche visto che le formiche assumevano verso questi oggetti un comportamento identico a quello tenuto nei confronti di una larva fuori posto. L’imitazione dei composti delle larve da parte degli afidi è chiamato aggressive mimicry (mimetismo aggressivo?) ed è un livello di tradimento di tutto rispetto. Cosa avrebbe potuto selezionare in un mite afide un comportamento di questo tipo?
Probabilmente la “versione piatta” di P.cimiciformis è nata come forma di resistenza a condizioni ambientali sfavorevoli. Mettiamoci un secondo nei panni di ‘sta bestia. Se va tutto bene e il mondo è pieno di piante, conviene avere figlie (partenogenesi ricordate?) tondo-verdi che si nutrono di linfa grezza e commerciano melata con le formiche in cambio di protezione. Se fuori butta al peggio, con freddo e umidità da far tremare un padano, produrre figlie che conoscano un modo per venire protette dalle formiche facendosi portare al sicuro dentro al nido può grantire loro sopravvivenza. Una volta nella camera delle larve bisognerà mangiare, e la selezione naturale favorirà quegli afidi capaci ad utilizzare l’unica fonte di cibo disponibile: le larve. Con il miglioramento delle condizioni ambientali l’afide potrà poi riprendere il suo ciclo vitale, producendo partenogeneticamente forme che si nutrono di linfa e non di sangue di infanti.
Almeno fino ai prossimi freddi.
FONTI
Salazar, A., Fürstenau, B., Quero, C., Pérez-Hidalgo, N., Carazo, P., Font, E., & Martínez-Torres, D. (2015). Aggressive mimicry coexists with mutualism in an aphid Proceedings of the National Academy of Sciences, 112 (4), 1101-1106 DOI: 10.1073/pnas.1414061112

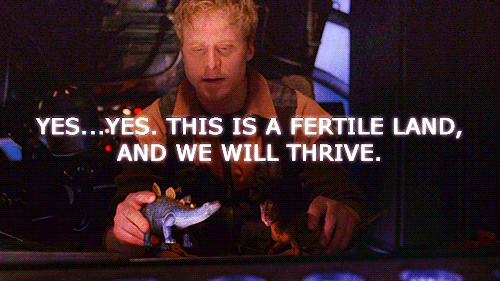


😮
Bastardi!
Bellissimo articolo.
Va detto che nella teoria dei giochi vale un principio simile, in pratica ogni gioco collaborativo a mosse alterne prevede che i due giocatori si accordino per avere un premio (eg. formare un oligopolio), però, ogni volta che si concorre a un premio si genera anche un’incentivo a tradire.
Appena l’incentivo a tradire supera il beneficio raggiunto collaborando scatta la coltellata.
La teoria dei giochi dice che siamo dei bastardi, la teoria dei giochi è gentile.
Tra l’altro le formiche si fanno fottere un po’ da tutti con sti scherzetti, che tongolone.